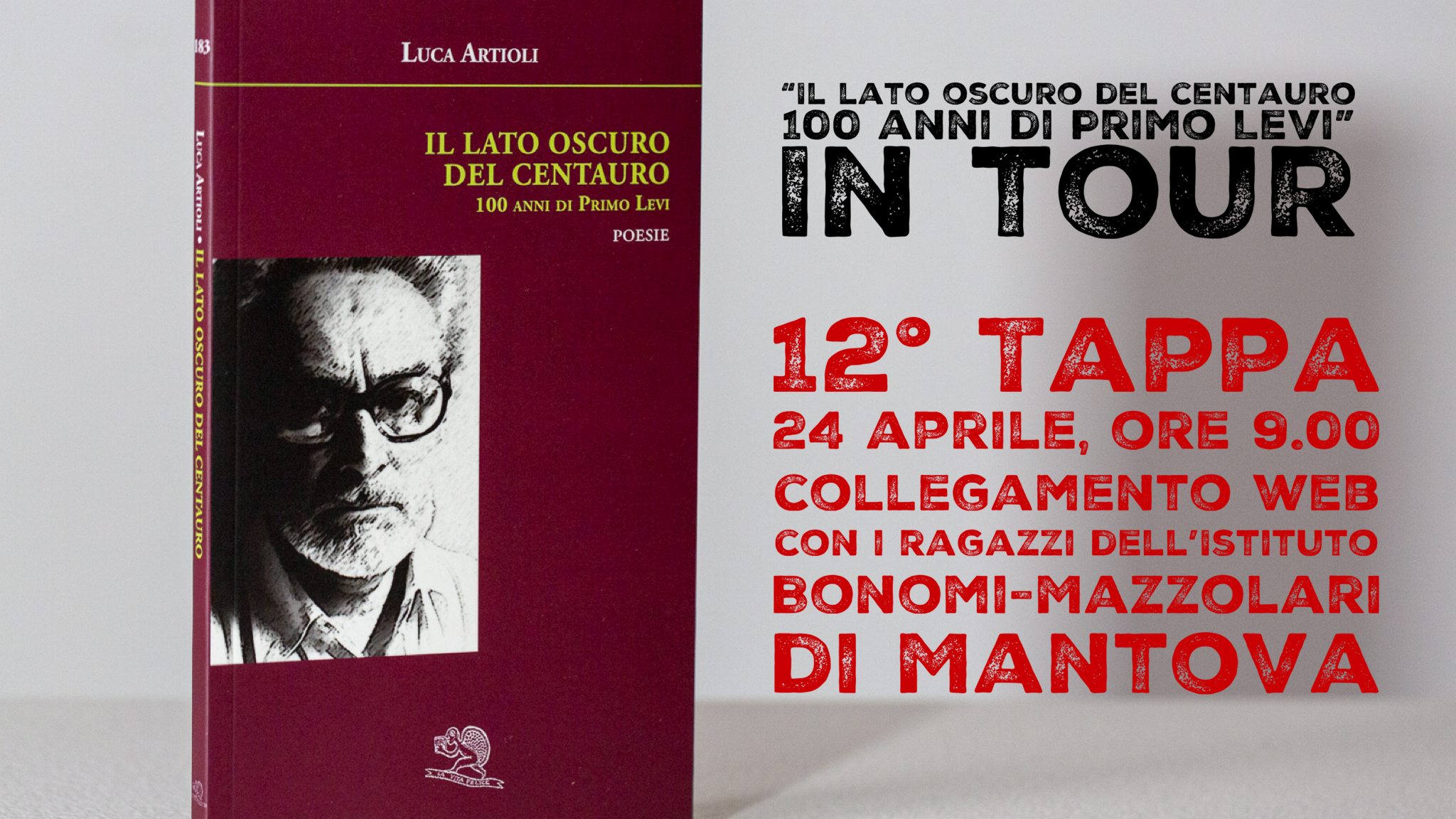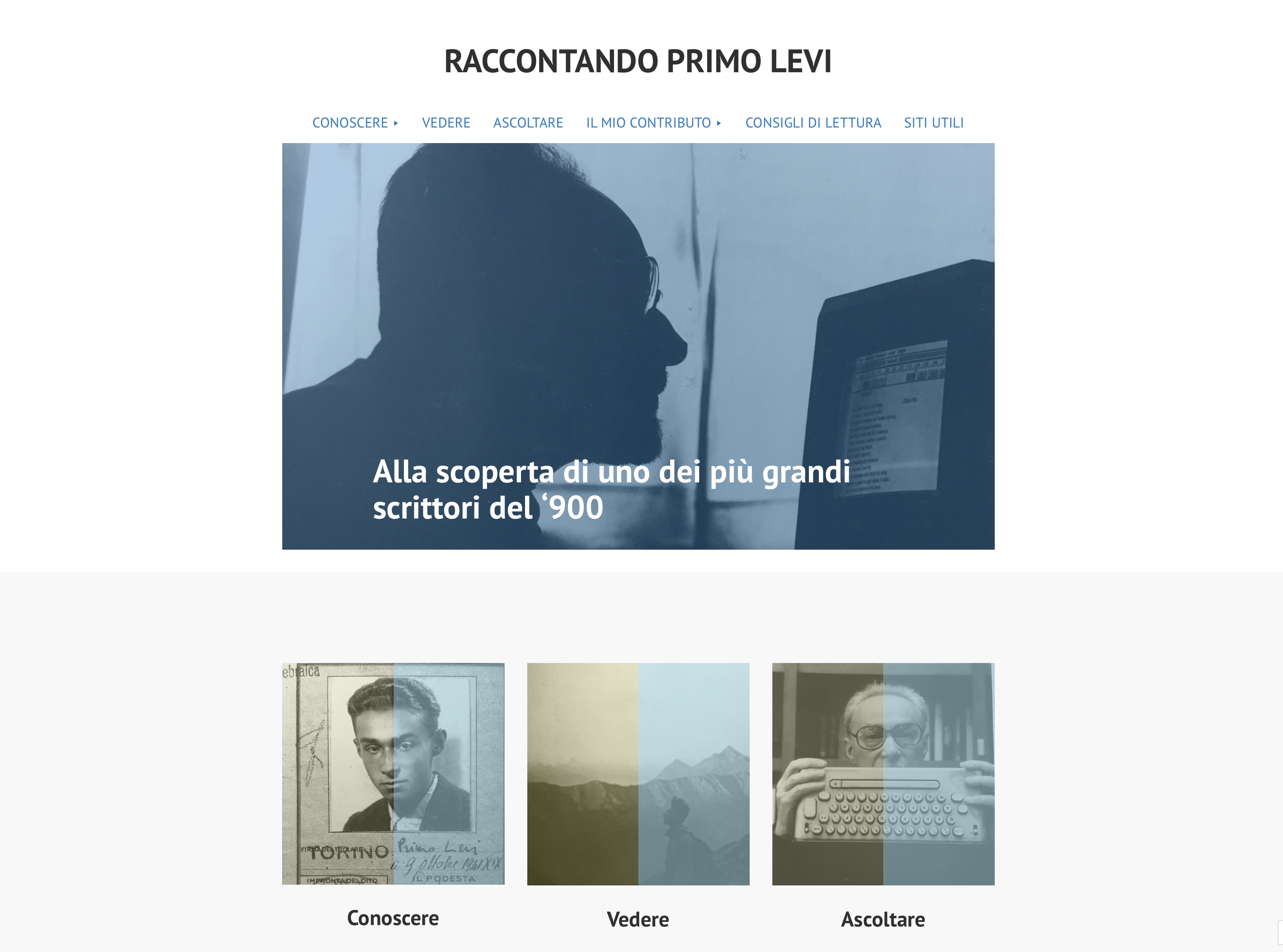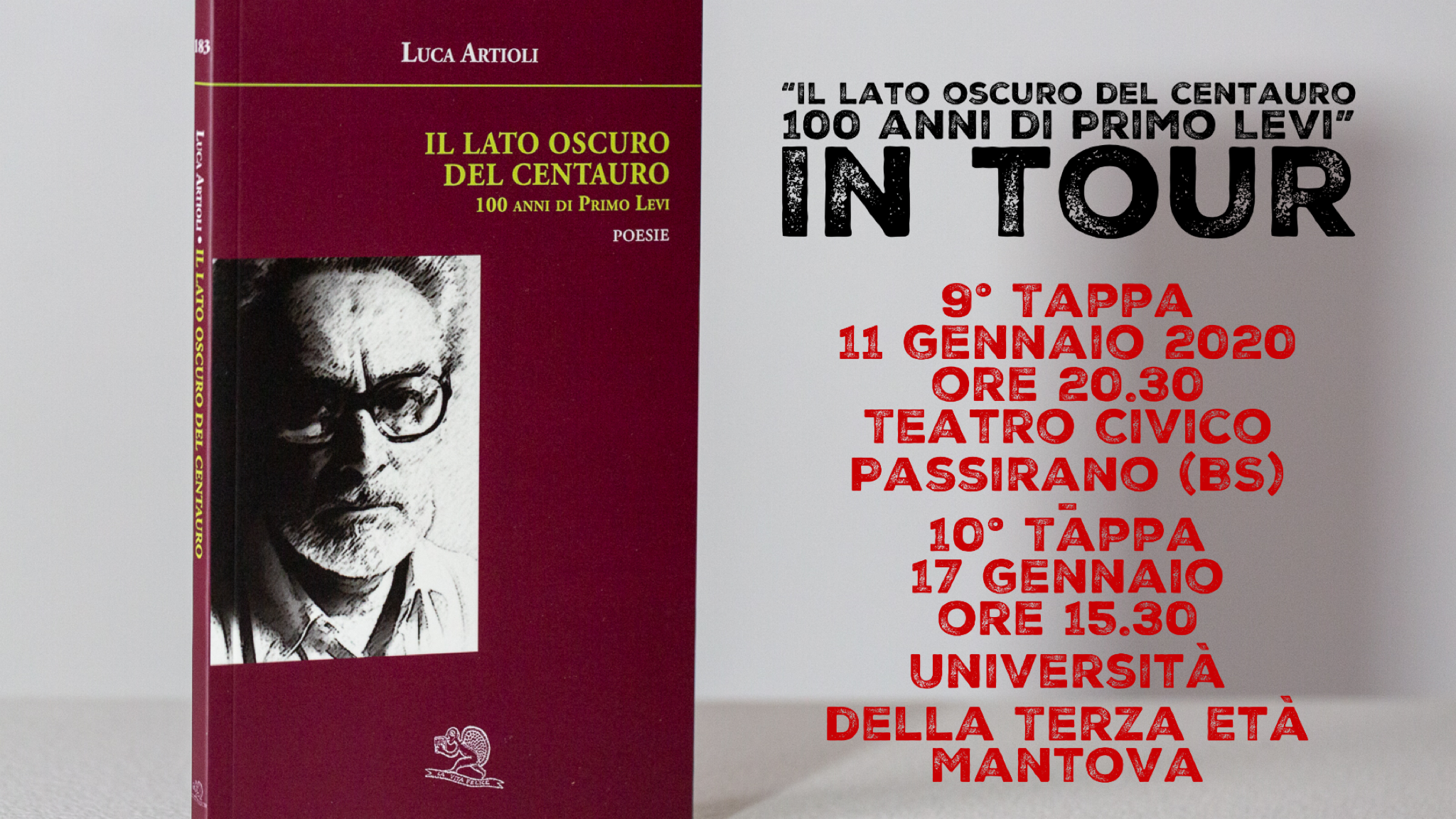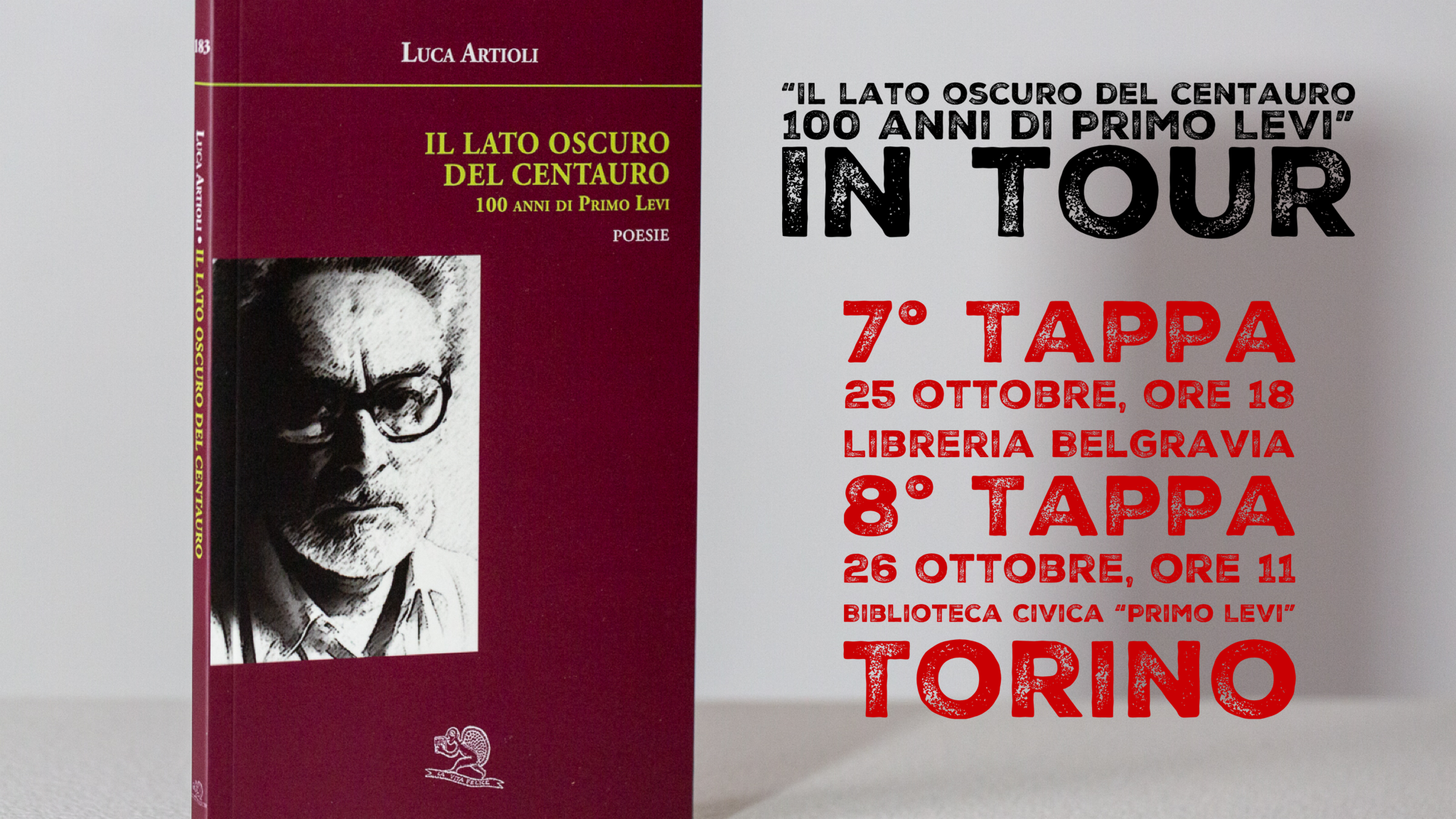Il blue singer non canta l’esistenza, ma il non morire, parla sempre di ciò che non ha e che non avrà mai. Il blues non è un modo di vedere, di interpretare la vita, i fatti, le cose: è la vita stessa, e tutto ciò che circonda il nero americano, tutto ciò che è triste, grigio.
Ma soprattutto è un fatto naturale, se non lo vivi, vuol dire che non lo hai.
E quella sera, al Blue Note, l’aria condensata e rarefatta dal tabacco lasciava presupporre che molte delle persone sedute in quel locale avessero i blues.
Figure come tratteggiate al carboncino, sfumate nella penombra concessa all’intimità dei tavoli, che si tenevano dentro la propria irrequietezza, il proprio vagabondare senza meta per riversarlo a se stessi e agli altri, alla prima occasione, dopo un bicchiere o alla fine della bottiglia.
In loro c’era l’esigenza di un’identità, il bisogno di una comune radice ed il blues ne accompagnava gli intenti, le conversazioni a mezza voce. I borbottii gutturali.
Dal sottofondo musicale, Big Bill Broonzy riportava l’immaginario alla New Orleans dei primi del Novecento: i bordelli, i cabaret, le sale da ballo con le bische nel retrobottega, il complesso caleidoscopio dell’America emancipata ed il suo proibizionismo.
Tutto sintetizzato in una progressione armonica, con il suo ritmo per di più lento, la sua incertezza, il suo quasi biologico respiro fondato su un tempo binario, dove la musica mostrava una propensione al discorso obliquo ed ogni nota non appariva mai attaccata direttamente a quella successiva, dove gli strumenti e la voce le si avvicinavano dall’alto al basso, giocando attorno alla sua altezza, senza mai soffermarvisi, per poi staccarsi bruscamente, abbandonandola in tutta la sua ambiguità.
Sulle pareti, la genesi del jazz.
Dipinti ad olio, fotografie 50x70cm, teche contenenti clarinetti, trombe e banjo tirati a lucido.
Ogni cosa appesa era lì per ricordare un fatto, un’impronta epocale nella storia della musica soul, fino a raggiungere il suo culmine nel trompe l’oeil dedicato a Miles Davis.
Dominava un’intera parete del Blue Note, quella dietro al pianoforte, e ritraeva il musicista durante un concerto, nel bel mezzo di una pausa.
I suoi occhi parevano guardarti per davvero.
Era seduto su una sedia, con le maniche della camicia bianca arrotolate, il gilet sbottonato.
Teneva in una mano un bicchiere colmo di liquido bronzeo, whiskey più che thè, e nell’altra la sua tromba.
Non se ne riusciva a staccare nemmeno durante i pochi minuti di riposo tra un pezzo e l’altro.
Le dita non si muovevano, ma davano l’idea che ne stesse accarezzando i pistoni, per tranquillizzarla, per farle capire che fosse presente.
Tu entravi nel locale e lui ti osservava, ti prendeva le misure, mentre sceglievi quale tavolo e quale sedia potessero fare al caso tuo.
E con chi ti aveva preceduto, divenivi parte della sua muta sonorità, quella velata e lieve, senza vibrato, che reclamava un lirismo fatto di frasi semplici e profonde.
Fu così che, appena misi piede al Blue Note, il Blue Note mise piede dentro di me.
Mi invase.
In maniera totalizzante.
Accomodato sopra uno degli sgabelli d’acciaio, dirimpetto al bancone, ordinai qualcosa abbozzando un cenno con la mano, mentre lo sguardo era rivolto altrove.
Lei arrivò prima che potessi desiderarla.
Pelle di pesca, sopravvento di labbra.
– Stasera canterò – esordì come a volersi far perdonare uno sbaglio mai commesso – canterò per te, canterò l’amore che non si può udire.
Poi le luci scesero improvvisamente fra di noi e dal suo sorriso una mezzanotte d’ebano ebbe inizio…