
Eccola qua, signori e signore, ecco finalmente Ochún, la dea dell’amore che abita i fiumi e che ora, a Santiago De Cuba, nella balera del vecchio Emilio País, si fa donna vera e balla la rumba come nessun’altra su quest’isola.
La notte è di quelle sudate e malinconiche, di quelle che le stelle ci si stanca a contarle presto, perché gli occhi fanno male e il cielo è troppo grande. José rulla appena sulla pelle del tamburo e la musica inizia a occupare ogni spazio, si arrampica sui muri, si appiccica alle gambe; Martín lo segue stringendo la chitarra e Joaquín tiene il tempo con le spalle che snocciolano bisbigli di maracas. Lei, la dea dell’amore che abita i fiumi, comincia così a muoversi, i suoi muscoli e i suoi tendini si flettono dentro un ritmo che la natura fatica a distinguere, dentro qualcosa di simile a una tempesta senza vento, con la schiena e i fianchi rotondi tutti frementi, in un tremore di uragani.
Pochi secondi di danza solitaria e la balera del buon Emilio è tutta una polveriera fatta di cosce accaldate, passi svelti e sorrisi maliziosi, con le mogli che non vogliono essere da meno a quel bocciolo di mariposa lì sul palco e alla sua eleganza distruttrice, perché l’orgoglio per il proprio corpo, signori e signore, è ancora cosa seria a Santiago.
E allora ecco Consuelo, che di chili ne fa oltre cento, ma che il marito con quella scollatura lo sa ancora incatenare senza tanti né quanti o Celia, caviglia esile e bocca amor di ciliegia, che nel bel mezzo della pista sussurra al fresco sposino qualcosa nell’orecchio, una frase che sa di promessa birichina e di generose concessioni.
Insieme a tutti gli altri, se ne stanno lì, a seguire quella musica, dove sono le note a tener il passo di Alejandra e non viceversa. Lei è la dea Ochún. Lei è il peccato e la rivoluzione. Lei è l’elisir che fa mischiare il sangue e ballare con voglia, finché il mattino arriva presto. Quando poi le luci si spengono una ad una, il locale del vecchio Emilio si svuota nella fretta di un baleno.
È allora che il tempo smette per un attimo di essere tempo.
Dietro al mio pianoforte, nel trambusto dei compagni che rimettono gli strumenti nelle custodie, Alejandra dea dell’amore che abita i fiumi mi butta la solita occhiata e mi sorride. “Amore mio” vorrei dirle in un suicidio di coraggio.
Amore mio.
Ma poi taccio, perché l’anima è già persa su quelle labbra che sono la carezza interminabile della ore buie. Alejandra, oh Alejandra, dea farfalla e pupilla di velluto, che fai delle mie parole soltanto macerie senza suono, affonda nel mio cuore il tuo sorriso-coltello ancora una volta e ricordami, ricordami di quanto dolore serva in questa notte per sentirsi vivi al di là di ogni ragione.
Al di là di ogni speranza.
(©Luca Artioli, 2009)

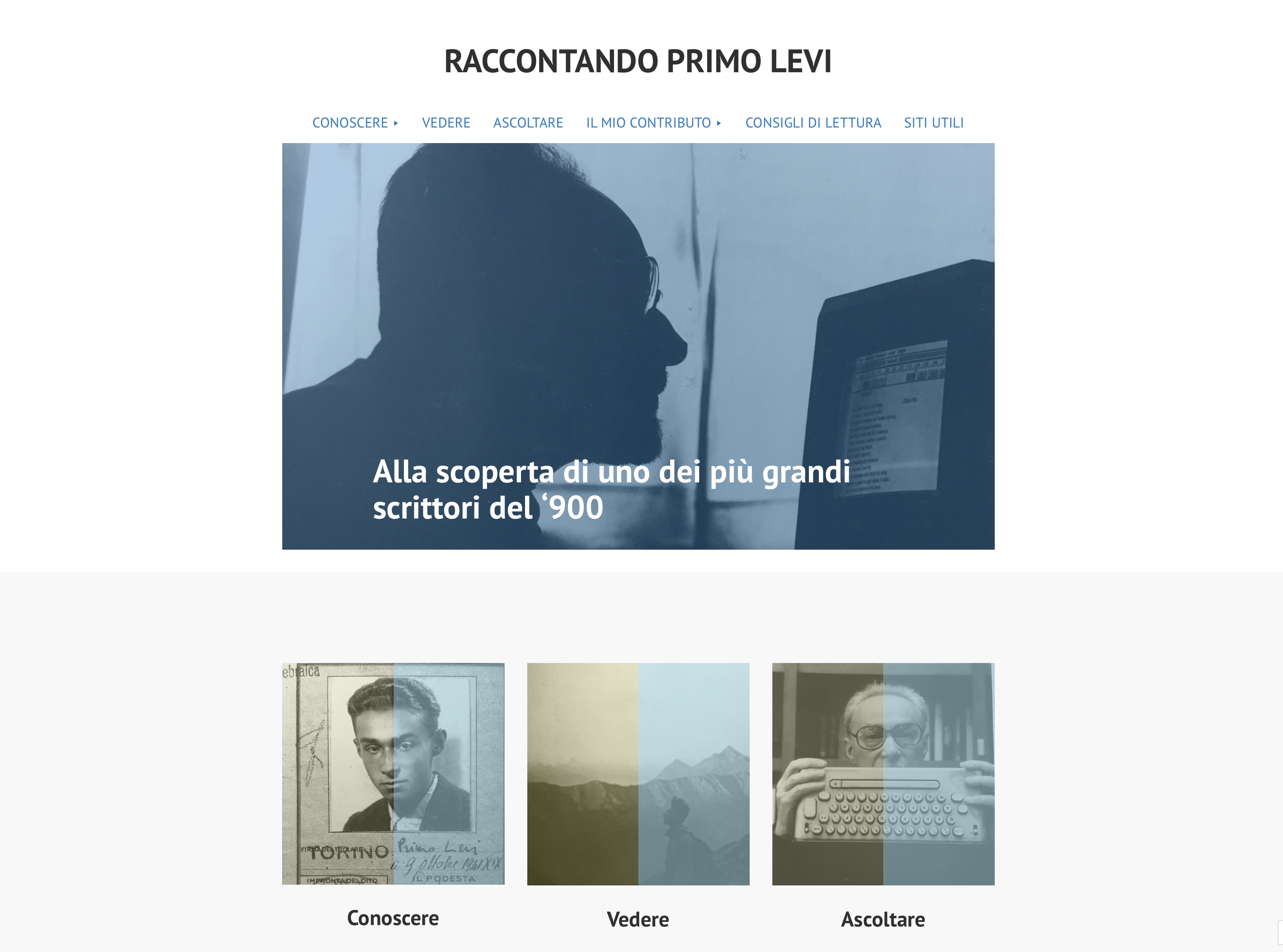

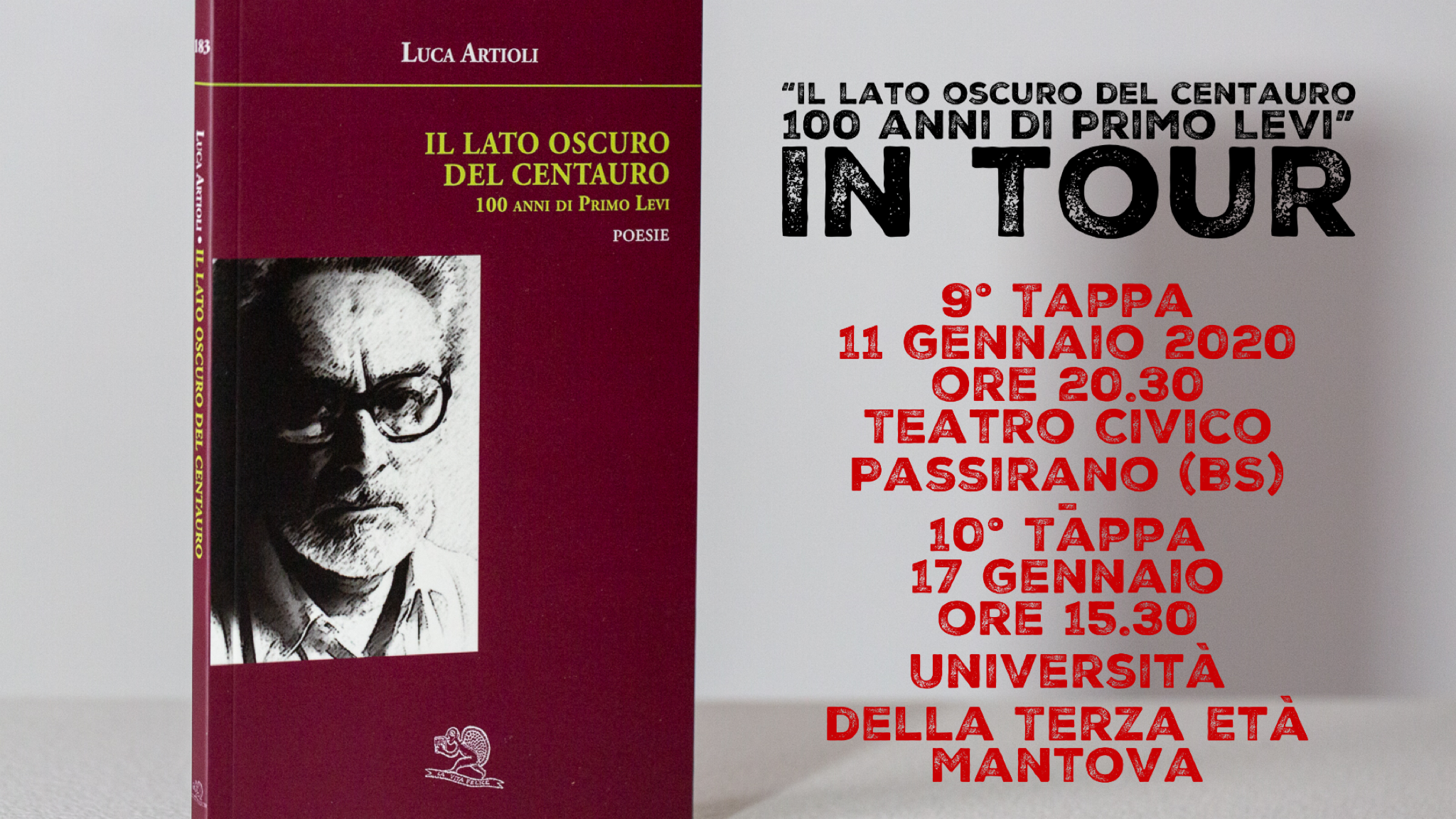
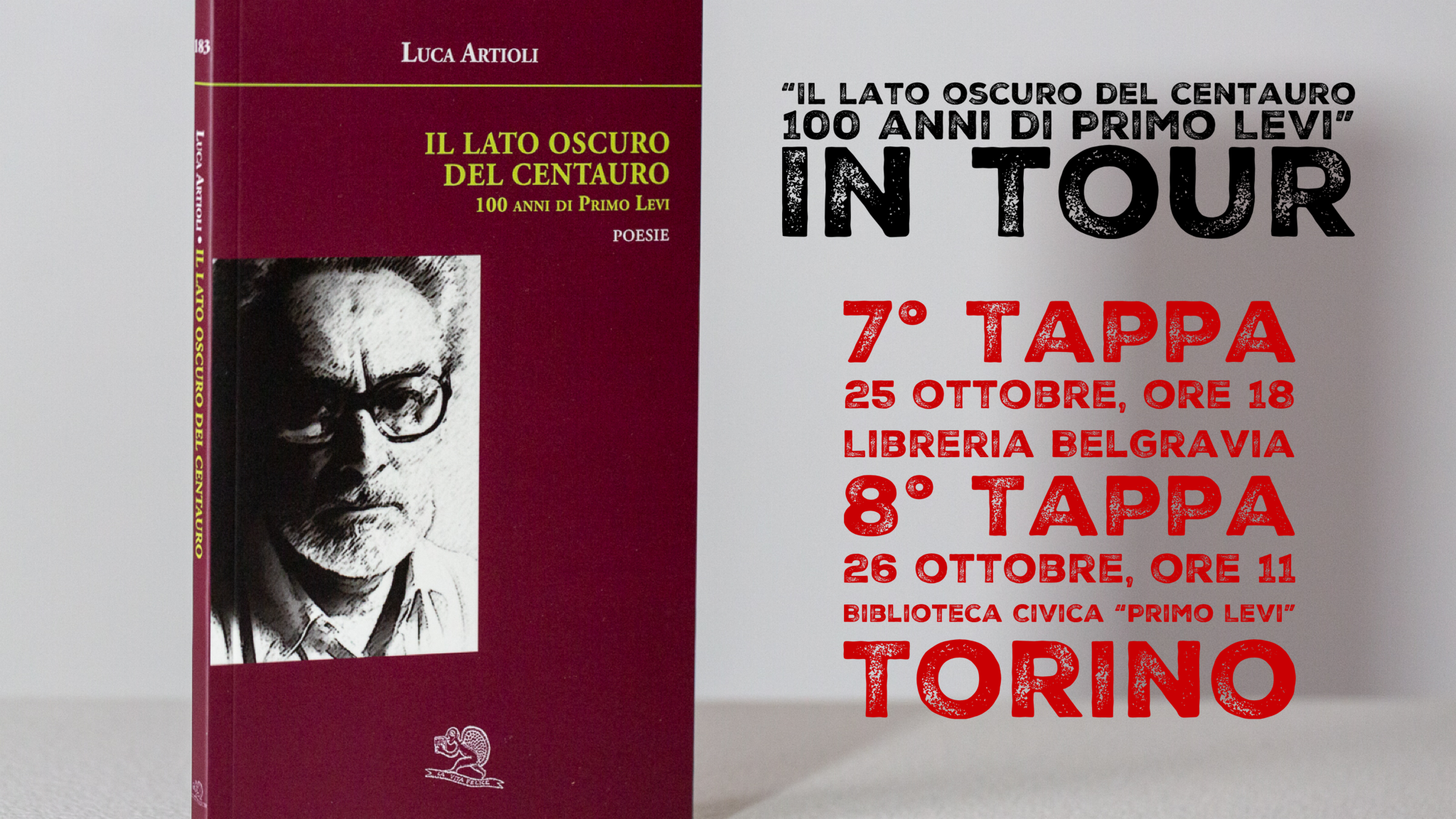

Bellissimo Luca, sembra di essere la, in quella sala da ballo negli occhi del pianista, che ha scritto la musica, struggente il suo suicidio di coraggio
Grazie mille Andrea! 🙂